La
Nascita del Teatro
Vi siete mai chiesto se i teatri sono
sempre esistiti? La risposta sembra
un facile sì. Tutti conoscono i
teatri dell’antica Grecia. C’immaginiamo che da allora fino ad oggi i
teatri, anche se cambiati ed evoluti nei secoli, sono sempre stati parte della
vita cittadina d’Europa.
Però ci sbagliamo.
Foto
©1997 Leo C. Curran
 Effettivamente il teatro, come
edificio, è nato nella Grecia antica. I
primi teatri consistevano in panche di legno poste su una collina in declivio,
con uno spazio piano davanti per le rappresentazioni.
I primi teatri in pietra furono costruiti verso la fine del VI secolo
a.C.; il teatro di Dionisio ad Atene risale al 544 a.C. eretto sotto la
direzione di Pisistrato. Dal quarto
secolo a.C. la struttura del teatro era compiutamente definita, come dimostra il
teatro di Epidauro (Epidaurus) con 12.300 posti, costruito nel 350 a.C. da Policlito
il Giovane.
Effettivamente il teatro, come
edificio, è nato nella Grecia antica. I
primi teatri consistevano in panche di legno poste su una collina in declivio,
con uno spazio piano davanti per le rappresentazioni.
I primi teatri in pietra furono costruiti verso la fine del VI secolo
a.C.; il teatro di Dionisio ad Atene risale al 544 a.C. eretto sotto la
direzione di Pisistrato. Dal quarto
secolo a.C. la struttura del teatro era compiutamente definita, come dimostra il
teatro di Epidauro (Epidaurus) con 12.300 posti, costruito nel 350 a.C. da Policlito
il Giovane.
I teatri greci erano sempre costruiti
fuori città, annesso ai templi, su una collina che offriva una formazione
facilmente adattabile alla struttura. Non
erano concepiti come strutture monumentali, ma esclusivamete funzionali. Il teatro greco consisteva nell’orchestra, una zona
circolare pavimentata con tavole di legno usato per le rappresentazioni, la
cavea, una serie di gradoni semicircolari appoggiati al terreno per ospitare gli
spettatori, e la skené, un edificio scenico che serviva da fondale, di
fronte alla cavea. Migliorava
l’acustica, senza nascondere il panorama.
La skené era tipicamente dotata di tre porte per le entrate in
scena, una centrale e due laterali. Lo
spazio tra la rettangolare skené e l’orchestra circolare si chiamava
“proskénion”. La cavea
era suddivisa in settori da uno o più scalette che la tagliavano a cuneo, e da
corridoi concentrici.
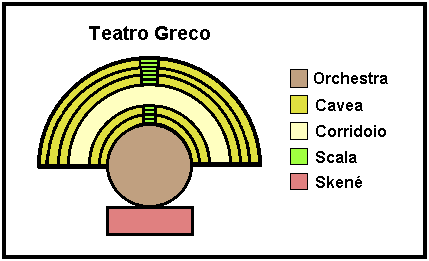 Le rappresentazioni erano
inizialmente legati strettamente alla religione, vi si svolgevano le feste
dionisiache. Dagli inni di queste
feste, detti ditirambi, nasce la tragedia greca.
Le rappresentazioni erano
inizialmente legati strettamente alla religione, vi si svolgevano le feste
dionisiache. Dagli inni di queste
feste, detti ditirambi, nasce la tragedia greca.
Tutta la popolazione assisteva agli
spettacoli. Ogni attività
lavorativa era sospesa e la perdita della giornata lavorativa era risarcita ai
cittadini più poveri tramite un gettone di presenza, il theorikon.
Queste celebrazioni, con sacrifici e recitazioni, duravano molto, dalla mattina
alla sera, spesso per più di un giorno. Gli
spettacoli, che includevano recitazione, musica, canto, e danze, si svolgevano
di giorno. Gli attori, cantanti e
ballerini usavano maschere per rappresentare il carattere e il sentimento; i
costumi erano standardizzati nel colore e negli attributi a seconda del
personaggio. Nel teatro greco si
faceva ampio uso di macchine sceniche.
Foto
©1997 Leo C. Curran
 Nell’antica Roma il concetto di
teatro ereditato dai greci è stato notevolmente sviluppato.
I primi teatri romani in pietra risalgono all’ultimo secolo della
repubblica (127 – 27 a.C.). Prima di allora, la legge proibiva la costruzione
di edifici permanenti per gli spettacoli, ma i teatri non permanenti in legno
erano straordinariamente sviluppati. Il
teatro costruito in legno da M.
Aemilius Scaurus nel 58 a.C.
contava 8000 posti, ed era sontuosamente decorato con oro e mosaici.
Il primo teatro costruito in pietra a Roma è il teatro di Gneo Pompeo a
Campo Marzio del 55 a.C.
Nell’antica Roma il concetto di
teatro ereditato dai greci è stato notevolmente sviluppato.
I primi teatri romani in pietra risalgono all’ultimo secolo della
repubblica (127 – 27 a.C.). Prima di allora, la legge proibiva la costruzione
di edifici permanenti per gli spettacoli, ma i teatri non permanenti in legno
erano straordinariamente sviluppati. Il
teatro costruito in legno da M.
Aemilius Scaurus nel 58 a.C.
contava 8000 posti, ed era sontuosamente decorato con oro e mosaici.
Il primo teatro costruito in pietra a Roma è il teatro di Gneo Pompeo a
Campo Marzio del 55 a.C.
Nel teatro romano i posti a sedere
sono arrangiati in semicerchi concentrici come quelli greci, ma gli architetti
romani hanno sviluppato la tecnica di sorreggere la struttura su archi e
corridoi a volte anziché appoggiarla ad un terreno in pendenza.
Così era possibile costruire un teatro ovunque, anche nel cuore delle
città. L’esterno diventa una
struttura monumentale, decorato con ordini di colonne ed archi sovrapposti a più
piani.
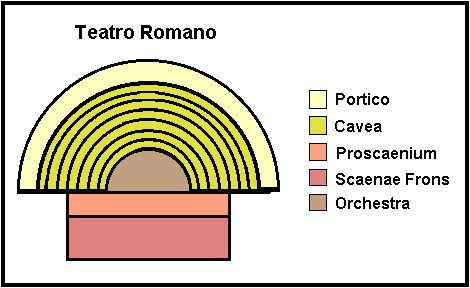 L’orchestra è semicircolare, più
piccola di quella greca, perché non vi si svolge più l’azione, che si sposta
nell’edificio scenico. La skené
diventa la scaenae frons, una struttura a più piani, alta ma poco
profonda, lungo il lato diritto dell’orchestra. Serviva da fondale e spesso
conteneva i camerini per gli attori; racchiudeva le tre porte ereditate dai
teatri greci. Era ornato con
elementi architettonici e sculture. Davanti alla scaenae frons
correva un palcoscenico rialzato denominato proscaenium, lateralmente
erano poste due quinte, o parascaenia, con una porta ciascuna per le
entrate laterali. I romani hanno
inventato il sipario (aulaeum) che si abbassava, scomparendo in un
apposito solco, all’inizio dello spettacolo.
L’orchestra è semicircolare, più
piccola di quella greca, perché non vi si svolge più l’azione, che si sposta
nell’edificio scenico. La skené
diventa la scaenae frons, una struttura a più piani, alta ma poco
profonda, lungo il lato diritto dell’orchestra. Serviva da fondale e spesso
conteneva i camerini per gli attori; racchiudeva le tre porte ereditate dai
teatri greci. Era ornato con
elementi architettonici e sculture. Davanti alla scaenae frons
correva un palcoscenico rialzato denominato proscaenium, lateralmente
erano poste due quinte, o parascaenia, con una porta ciascuna per le
entrate laterali. I romani hanno
inventato il sipario (aulaeum) che si abbassava, scomparendo in un
apposito solco, all’inizio dello spettacolo.
La cavea romana era divisa in diversi
ordini, separati tra loro da parapetti, accessibili da gallerie.
Un portico a colonne stava sopra la cavea per ospitare altri spettatori.
Gli spettatori più ragguardevoli si sedevano nelle prime file e
nell’orchestra, quelli meno abbienti nei settori successivi e i più poveri
nel portico.

Foto
©1997 Leo C. Curran
I teatri romani più spettacolari
rimasti sono quelli di Orange, Francia dell’inizio del I secolo d.C. e di
Sabratha, Libia, della fine del II secolo d.C. Uno dei più monumentali è il
Teatro di Marcello, dedicato al nipote dell’imperatore Augusto, costruito dal
13 al 11 a.C., capace di ospitare dai 15.000 ai 20.000 spettatori.
A Volterra la scaenae frons del piccolo teatro romano è stata
parzialmente ricostruita.
L’anfiteatro è un altro sviluppo
dell’edificio teatrale. Significa
letteralmente teatro rotondo. Consisteva
in un’area ellittica circondata da posti a sedere su tutti i lati.
Gli anfiteatri erano di due tipi: appoggiati su un terrapieno e
interamente costruiti. Nell’antica
Roma vi si svolgevano combattimenti di animali e gladiatori, e giochi atletici.
Il primo anfiteatro conosciuto è quello di Pompei di 75 a.C. circa. Il più grande era l’Anfiteatro Flavio, noto come il
Colosseo per una statua colossale di Nerone che si trovava vicino, costruito tra
70 e 80 d.C. a Roma. Conteneva
50,000 spettatori, circa la stessa capienza di uno stadio moderno.
Esigenze climatiche, e la ricerca di
uno spazio teatrale più intimo, hanno portato allo sviluppo dell’odeon, un
teatro al chiuso che si poteva usare in qualsiasi condizione meteorologica. L’odeon era essenzialmente uguale al teatro romano
con l’aggiunta dei muri laterali e del tetto in legno. E’ probabilmente uno sviluppo del bouleuterion
greco, uno spazio al chiuso per assemblee con gradinate per il pubblico, uno
spazio centrale, e un tetto in legno sostenuto da colonne.
L’odeon di Pompei del 80 a.C. conteneva mille spettatori.
Vi si svolgevano spettacoli di musica, teatro, recitazioni di poesie e
pantomime, spettacoli paragonabili ai moderni spettacoli di danza, accompagnati
da strumenti musicali e dal coro.
Mimo, un tipo di spettacolo
teatrale recitato
senza maschere, che prevedeva l’impiego di scene di sesso dal vivo, violenza,
e morte (condannati a morte sostituivano gli attori all’ultimo momento e
furono uccisi sulla scena), divenne popolare nel tardo impero.
Per la natura di questi spettacoli, e il forte legame tra tutto il teatro
classico e la religione pagana, la chiesa cristiana disapprovava il teatro.
Nel 312 d.C. l’imperatore
Costantino impone la Cristianità come unica fede dell’impero.
Già alla fine del secolo, sotto l’imperatore Teodosio, le
rappresentazioni erano vietate la domenica e nei giorni festivi. Nel corso del 4°
secolo d.C. gli attori, e dopo anche gli spettatori, sono scomunicati.
Gli ultimi teatri romani furono costruiti nel 3° secolo d.C.; l’ultima
notizia di uno spettacolo teatrale nell’antichità risale al 533 d.C.
Per 400 anni il teatro, e i teatri,
non esisteranno più. I teatri e
gli odeon romani crollano, le pietre vengono usate come materiale di costruzione
per nuovi edifici.
Solo nel 9° secolo il teatro si
riaffaccia nella storia occidentale. Nascono
i drammi di misteri e miracoli. Questi
drammi erano inizialmente rappresentati a Pasqua ed a Natale da ecclesiastici
all’interno delle chiese, con le varie scene organizzate in sequenza attorno
alla navata principale.
Col tempo i drammi sono stati
spostati all’esterno, sulle scale delle chiese e su piattaforme temporanee
costruite per l’occasione. Il
pubblico si spostava seguendo la storia con un ordine prestabilito.
Spostando il dramma fuori dalle chiese, i membri delle corporazioni
medievali e, più tardi, attori professionisti hanno sostituito i sacerdoti come
attori.
Durante tutto il Medioevo, il teatro
si svolgeva con queste modalità, che oggi si definisce “spettacolo
itinerante”. Non è stato
costruito alcun edificio teatrale.
Con il rinascimento è nato un nuovo
interesse per l’antichità classica. Gli
studiosi hanno letto i drammi classici rimasti, e studiato e tradotto il
trattato di Vitruvio sull’architettura. Vitruvio
ha dedicato la maggior parte del 5° Libro alla costruzione e all’acustica dei
teatri. Questi studiosi avvertivano
un vuoto culturale dove una volta c’era il teatro. Cresceva la voglia di fare rivivere il teatro come luogo, e
di riempirlo di nuovi contenuti nello stile antico.
Home
La storia dello spazio teatrale prosegue con il Rinascimento
©
2003 Ballet Academic Studio
 Effettivamente il teatro, come
edificio, è nato nella Grecia antica. I
primi teatri consistevano in panche di legno poste su una collina in declivio,
con uno spazio piano davanti per le rappresentazioni.
I primi teatri in pietra furono costruiti verso la fine del VI secolo
a.C.; il teatro di Dionisio ad Atene risale al 544 a.C. eretto sotto la
direzione di Pisistrato. Dal quarto
secolo a.C. la struttura del teatro era compiutamente definita, come dimostra il
teatro di Epidauro (Epidaurus) con 12.300 posti, costruito nel 350 a.C. da Policlito
il Giovane.
Effettivamente il teatro, come
edificio, è nato nella Grecia antica. I
primi teatri consistevano in panche di legno poste su una collina in declivio,
con uno spazio piano davanti per le rappresentazioni.
I primi teatri in pietra furono costruiti verso la fine del VI secolo
a.C.; il teatro di Dionisio ad Atene risale al 544 a.C. eretto sotto la
direzione di Pisistrato. Dal quarto
secolo a.C. la struttura del teatro era compiutamente definita, come dimostra il
teatro di Epidauro (Epidaurus) con 12.300 posti, costruito nel 350 a.C. da Policlito
il Giovane. 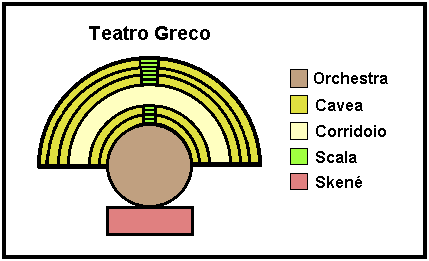 Le rappresentazioni erano
inizialmente legati strettamente alla religione, vi si svolgevano le feste
dionisiache.
Le rappresentazioni erano
inizialmente legati strettamente alla religione, vi si svolgevano le feste
dionisiache. Nell’antica Roma il concetto di
teatro ereditato dai greci è stato notevolmente sviluppato.
Nell’antica Roma il concetto di
teatro ereditato dai greci è stato notevolmente sviluppato.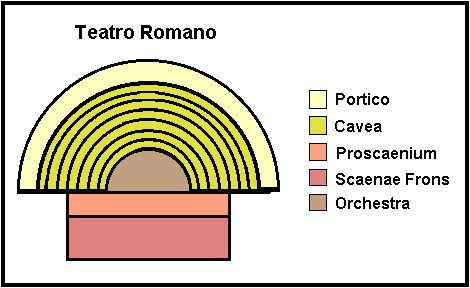 L’orchestra è semicircolare, più
piccola di quella greca, perché non vi si svolge più l’azione, che si sposta
nell’edificio scenico.
L’orchestra è semicircolare, più
piccola di quella greca, perché non vi si svolge più l’azione, che si sposta
nell’edificio scenico.